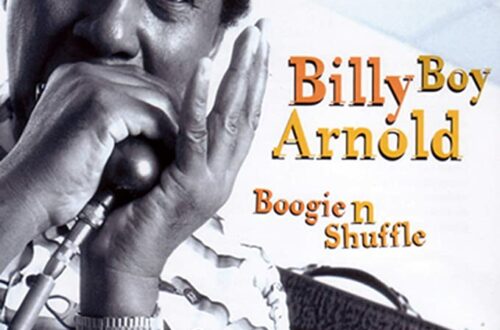Ercole Bassi: Collettivismo e lotta di classe 1919
Ercole Bassi
Collettivismo e lotta di classe
(1919)
a cura di Gianni Ferracuti
Il testo è un opuscolo di propaganda pubblicato nel 1919 dal Fascio Popolare di Educazione Sociale di Milano. In quest’epoca il termine fascio appartiene ancora al lessico della sinistra radicale: identifica un raggruppamento o un’associazione a carattere politico o sindacale o un coordinamento di vari gruppi convergenti su un progetto politico; il termine era già diffuso nel secolo precedente e anche graficamente il fascio era stato il simbolo del Partito Radicale.
Nell’immediato dopoguerra vengono fondati fasci in ogni regione del Paese ad opera di sindacalisti rivoluzionari, fuoriusciti dal partito socialista, ex combattenti, futuristi… organizzazioni che confluiranno, nell’una o nell’altra forma, nei Fasci Italiani di Combattimento, costituiti a Milano il 23 marzo 1919, a Piazza San Sepolcro, i cui principali promotori sono Marinetti, Mussolini, De Vecchi, gli arditi di Mario Carli, i sindacalisti rivoluzionari con Alceste de Ambris, a cui si deve la parte economica del cosiddetto programma di sansepolcro, o sansepolcrista, e i nazionalisti di sinistra di Corradini.
Vi confluisce anche il Fascio Popolare di Educazione Sociale, che era stato fondato l’anno precedente su iniziativa di Luigi Lojacono (che poi sarebbe stato Sottosegretario al Ministero delle Comunicazioni dal 1932 al 1935), insieme a Mario Floriani, volontario di guerra e collaboratore del Popolo d’Italia (“Quotidiano Socialista” fondato da Mussolini), che ne dà notizia il 7 dicembre 1918, con una nota intitolata Un’iniziativa di combattenti: Per un fascio popolare di educazione sociale, corredata da una breve nota redazionale di approvazione. I contatti con i Fasci di combattimento sono riferiti in un articolo di Mussolini, sempre sul Popolo d’Italia, il 3 luglio 1919: Oggi il fascismo è la forza più audace.
L’amalgama di forze di sinistra confluite nei Fasci si era già compattato sull’interventismo nella prima guerra mondiale, intesa come guerra rivoluzionaria destinata ad abbattere gli imperi reazionari: quello austro-ungarico e quello zarista, nello stesso tempo in cui avrebbe permesso di portare a termine l’unità d’Italia, estendendola alle “terre irredente”, e di rivoluzionare la struttura economica del Regno sabaudo. Pochi mesi dopo la riunione di Piazza San Sepolcro, tutte le componenti presenti si sarebbero ritrovate a sostenere l’impresa di D’Annunzio a Fiume (sia pure con qualche perplessità circa le reali intenzioni di Mussolini). Nel 1920, proclamando a Fiume la Reggenza Italiana del Carnaro, il Comandante D’Annunzio e De Ambris predisponevano una carta costituzionale, la Carta del Carnaro (essa sì la più bella costituzione del mondo), che trasformava il programma sansepolcrista in una concezione organica dello Stato e della società.
Disgraziatamente, l’impresa di Fiume finisce in modo tragico, con l’attacco della Regia Marina italiana alla città istriana e la sconfitta del Comandante nel cosiddetto natale di sangue del 1920. Al momento dello scontro finale, Mussolini di fatto si tira indietro, sostanzialmente concordando col Governo un’opposizione nominale e di facciata all’attacco contro la Reggenza fiumana.
La svolta di Mussolini (ragionando ora in termini esclusivamente politici) non è priva di una sua logica e prelude alla successiva svolta “reazionaria” realizzata con la fondazione del Partito Nazionale Fascista. Infatti, la fine dell’impresa dannunziana dimostra che, inequivocabilmente, le forze armate italiane restano fedeli al re e non è possibile immaginare un percorso rivoluzionario senza di esse; e se non ottiene l’appoggio delle forze armate uno straordinario ed amato eroe di guerra come D’Annunzio, non può ottenerlo nessun altro. Detto più chiaramente: l’idea di partire da Fiume per marciare su Roma non rientra nelle possibilità offerte dalla situazione. Mussolini, dunque, mette da parte D’Annunzio, accantonando ogni altra considerazione, per tentare un diverso cammino politico che definirei: una rivoluzione dall’alto, passando attraverso un compromesso con la monarchia e con le forze economiche che ad essa fanno riferimento.
Mussolini copierà tutto ciò che è stato creato dai futuristi e, soprattutto da D’Annunzio: le divise, i discorsi dal balcone, l’azione diretta, il pugnale tra i denti e l’esaltazione degli arditi, il me ne frego e l’eia eia alalà, i riferimenti alla romanità (ben più raffinati nel Comandante), dirottando tutto questo in una via istituzionale: garantisce alla monarchia il controllo dell’ordine pubblico, la sopravvivenza contro le spinte repubblicane dei movimenti e dei fasci, la protezione dall’incipiente comunismo, e in cambio ottiene il governo, passando attraverso la quasi farsa della marcia su Roma del 1922. Quasi farsa, ma sostanzialmente una recita in cui gli attori non si fidano l’uno dell’altro: Dino Grandi, che non era uno sciocco, aveva capito che la marcia su Roma non avrebbe avuto alcuna speranza se solo l’esercito avesse avuto l’ordine di sparare; ma non lo ebbe. Allo stupito ministro Facta, che chiedeva giustificazione al re del mancato intervento, “Sciaboletta” farfugliò scuse senza senso, non potendo dire che rispettava i patti con Mussolini.
Qui, però, comincia una storia che ora non ci interessa. Con la svolta di Mussolini, una parte del movimento rivoluzionario entrerà nel Partito Nazionale Fascista, e un’altra parte cercherà di fermarlo, anche a colpi di bombe a mano, con l’aiuto dei vecchi socialisti e della pattuglia dei comunisti, costantemente in ritardo rispetto all’evoluzione politica. Il biennio 1920-22 vede in prima fila contro i fascisti gli arditi del popolo, i sindacalisti rivoluzionari di De Ambris e, minoritari, i socialcomunisti.
Tornando al testo, evidentemente non si tratta di un esaltante trattato di teoria politica: è un opuscolo di propaganda, ma proprio per questa sua finalità pratica ha in interesse straordinario perché mostra quali sono i grandi temi discussi nel momento. L’autore, Ercole Bassi, è un avvocato di Delebio, in Valtellina, che ha un incarico come magistrato a Milano; è vicino al movimento cooperativo, ma sostanzialmente la sua pubblicistica politica è molto scarsa. Le argomentazioni, però, sono interessanti.
L’obiettivo polemico del libello, pur parlandosi di socialismo, è in realtà l’incipiente comunismo italiano che, dopo il colossale errore politico di non capire i fasci di San Sepolcro né l’impresa di Fiume, compie la scelta suicida di sposare le formule politiche della rivoluzione di Lenin in Russia. Si può capire che questa sinistra, ancora molto ottocentesca, si esalti per la vittoria del proletariato in Russia, ma questa esaltazione la condividevano anche i futuristi e i dannunziani e, gli articoli del Popolo d’Italia lo testimoniano, anche Mussolini. La differenza era, però, su un’altra questione, cioè se questa meravigliosa rivoluzione proletaria avesse elaborato soluzioni applicabili anche alle società europee, più articolate, più variegate, con una gamma di soggetti sociali attivi ben più ampia di quella che costituiva la più livellata società russa: i comunisti italiani cominciano a parlare di collettivizzazione quando già i futuristi parlano da anni di azionariato sociale e il socialismo europeo ha elaborato un pensiero sindacale avanzato con Sorel e, in Italia, con il comunismo critico di Labriola.
Dunque, l’obiettivo polemico del testo è appunto l’idea di collettivizzazione comunista nella sua proposizione come soluzione ai problemi italiani. In alternativa, viene invece proposto lo sviluppo e l’incremento del movimento cooperativo, con una progressiva estensione della proprietà. Però, a differenza di formulazioni ottocentesche dello strumento cooperativo, vi è qui un’influenza del sindacalismo rivoluzionario, nel senso che la cooperazione, che ha origine da un’iniziativa autonoma delle forze sociali, deve essere supportata dallo stato: lo stato non è neutrale, come nel pensiero liberale o, in parte, nel solidarismo cattolico, ma è soggetto politico attivo che assume iniziative politiche a sostegno dei soggetti sociali deboli, produce servizi di welfare e interviene sulla contrattazione come elemento equilibratore, la cui missione è la giustizia sociale.
Come era apparso chiaro a De Ambris, dopo le sconfitte del sindacalismo rivoluzionario all’inizio del secolo, lo stato non è uno strumento destinato, utopisticamente, a sparire una volta realizzato il socialismo, ma è concretamente lo strumento che realizza il socialismo e nel tutela la conservazione.